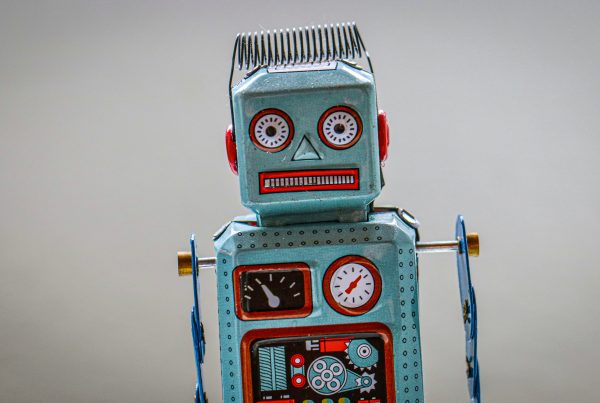Per muoversi in direzione del cambiamento, occorre viaggiare leggeri. L’effetto di alcune parole, tuttavia, è quello di appesantire; definendo le persone, come sassi nelle tasche, le inchiodano ad una realtà patologica, radicata a terra. Per non cadere nella trappola, è necessario comprendere l’importanza di svincolarsi dal lessico della malattia, per potersi sollevare verso narrazioni di sé che siano libere dalla paura e dallo stereotipo.
Si è abbondantemente parlato in questi ultimi giorni a proposito di salute mentale, proprio in occasione della giornata mondiale dedicata. I social network sono stati invasi da post di conoscenti e colleghi, tutti scritti con l’intento di sdoganare un tema ancora oggi circondato da luoghi comuni, timori e pregiudizi. Tuttavia, leggendo alcune frasi (del tipo “la malattia mentale è una malattia come le altre, si può guarire”), ho notato come continui ad essere presente una retorica di stampo medico, persino quando si sta parlando di salute psicologica… retorica dalla quale, ritengo, sarebbe ora di affrancarsi!
Mi sono dunque preso del tempo, così da mettere per iscritto alcune riflessioni.
Nell’odierna società medicalizzata è prevalentemente diffuso l’utilizzo di un lessico che fa riferimento alla malattia anche quando vogliamo invece parlare di salute; questi due aspetti – salute e malattia – vengono considerati e di conseguenza trattati come estremi opposti di una dimensione unica, come elementi dicotomici e in qualche modo inseparabili.
Ma cosa si intende, innanzitutto, per “salute”? Rappresenta la ricerca di una migliore qualità di vita o la mera assenza di malattia? Quale dovrebbe essere l’obiettivo dei professionisti della sanità?
Un’ulteriore domanda si aggiunge all’elenco: in che modo il lessico della malattia influisce sulla salute psicologica e sul benessere degli individui? Per rispondere, si consideri come il linguaggio condiziona la nostra maniera di percepire e di costruire la realtà che ci circonda. Ad esempio, descrivere un ambiente come “spoglio” o usare piuttosto il termine “minimale” altera il modo che si ha poi di viverlo e di percepirlo. Bisogna perciò stare molto attenti alla scelta del linguaggio: sia a come lo si utilizza, che al contesto e agli interlocutori.
Di fatto, il vocabolario del professionista e delle istituzioni che si occupano di salute mentale prevede comunemente l’uso di una vasta terminologia che comprende parole quali: malattia, patologico, paziente, diagnosi, cura, guarigione. Come anticipato, per parlare di salute spesso si finisce per parlare di malattia.
“I limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo”, diceva Ludwig Wittgenstein. Se la parola definisce i limiti del mondo, dunque, il mondo del paziente rischia di declinarsi soltanto entro i limiti della malattia. Svincolarsi dal lessico della malattia significa, appunto, svincolarsi da una realtà che considera l’individuo principalmente o unicamente in quanto malato. Ciò vale tanto nei contesti quotidiani quanto nell’ambito della psicoterapia.
Tale linguaggio contribuisce inoltre a mantenere i numerosi pregiudizi che ancora circondano la malattia mentale. Con essi, prosperano i sentimenti di paura e diffidenza nei confronti del folle, che finisce per rivestire il ruolo di emarginato sociale (qui potete approfondire il tema del ruolo designato). Nonostante il decisivo ruolo di Franco Basaglia nella lunga lotta allo stigma sociale e alle istituzioni psichiatriche in Italia, il lessico della malattia rappresenta tutt’oggi una delle ignare forme di abuso psicologico messe in atto da parte di diverse figure professionali e istituzioni mediche, seppure in maniera molto ridotta e in buona fede, che nel tentativo di aiutare la persona la relegano invece nel ruolo di paziente. La persona giunge così ad assumere per sé l’unica identità che gli viene costantemente restituita e rafforzata, l’unica nella quale è in grado di riconoscersi, cioè quella del malato.
È dunque comprensibile la comune tendenza a rifuggire da tutte quelle pratiche che parlano il linguaggio della malattia. È così che il pregiudizio finisce spesso per coinvolgere l’intero ambito della psicologia, legata alla follia dal senso comune – così come l’idea di salute appare erroneamente vincolato a quella di malattia. Tutto ciò dà origine ad un altro grandissimo preconcetto, tremendamente difficile da scardinare: lo psicologo è per i matti.
Il timore della follia, oltre a rivolgersi verso l’esterno – verso l’altro – può infatti rivolgersi anche verso l’interno – cioè verso se stessi. La diffidenza nei confronti dello psicologo, in questo senso, è spesso figlia della paura di essere “matti”: la psicoterapia è solo per i matti, quindi a me non serve, altrimenti vorrebbe dire che io sono matto, non ho bisogno di essere curato. Questo tipo di ragionamento è chiaramente vincolato ad una logica di stampo medico e ad un linguaggio che richiama gli aspetti della malattia.
Ma il lavoro dello psicologo va oltre a tutto ciò. È necessario ovviamente che il professionista sia svincolato da tale logica. Si ritorna così al concetto di salute intesa come miglioramento della qualità di vita e come ricerca del benessere psicofisico, invece che considerarla in quanto semplice assenza di malattia.
In psicoterapia, attribuire alla persona una diagnosi costituisce sempre un rischio. Sia per il professionista, che può cadere nella trappola del preconcetto e rimanerne dunque influenzato, sia per il cliente che si sente affibbiare un’etichetta problematica. In tali circostanze, il lessico della malattia contribuisce a generare una realtà patologica nella quale l’individuo resta incastrato; ciò ostacola qualsiasi tentativo di progettare insieme – cliente e terapeuta – delle nuove possibilità di esistere al di fuori della malattia.
I rischi specifici che possono presentarsi sono molteplici. Tra questi, i più comuni possono essere raggruppati come segue:
- il rischio di spingere la persona verso un baratro emotivo
→ Ricevere una diagnosi di depressione, ad esempio, può significare per qualcuno non avere più via di scampo. Talvolta ci si può addirittura convincere di essere realmente depressi, poiché lo dice l’esperto. - il rischio di legittimare i comportamenti disfunzionali
→ La diagnosi può portare ad una deresponsabilizzazione dell’individuo, che si sente quindi libero di perpetuare i suoi atteggiamenti negativi. In altri termini, è come se gli si dicesse “puoi comportarti così perché sei malato”. Ciò fa parte del processo di mantenimento dei vantaggi secondari che derivano dallo status di malato. - il rischio di generare la “malattia”
→ Attraverso la diagnosi si innescano una serie di processi ricorsivi (come quelli esposti nei punti precedenti) che alimentano il disagio e in certi casi generano la malattia stessa, trasformandola da un vissuto soggettivo in qualcosa di oggettivo e “reale”. È la diagnosi, dunque, a produrre la malattia e non viceversa.
Ecco quindi perché nel mio approccio il solo vincolo lessicale è quello che mi lega all’altrui soggettività. Perché l’attenzione sia rivolta alla persona e non alla diagnosi, che troppe volte nasconde l’individualità dell’altro; perché si possa costruire una relazione tra individui e non tra dottore e paziente; per prendersi cura della persona, non per curare la malattia. In sintesi, per poter promuovere efficacemente la salute e il benessere psicologici.
Liberiamoci dal peso del pregiudizio, svincoliamoci dal lessico della malattia e spogliamoci dei sentimenti di diffidenza e timore che esso contribuisce a diffondere.